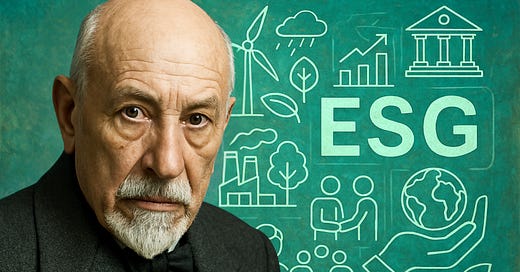Una, nessuna e centomila: la sostenibilità lungo la catena del valore
di Cesare Tomassetti
Nel suo capolavoro del 1926 “Uno, nessuno e centomila”, Luigi Pirandello ci consegna una vertigine identitaria senza tempo: siamo ciò che crediamo di essere o, piuttosto, l’immagine che gli altri proiettano su di noi? Il tormento interiore del protagonista Vitangelo Moscarda trova un’eco contemporanea nel mondo delle imprese e della sostenibilità.
Nell’era della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), della CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), dei rating ESG, degli audit di seconda e terza parte, l’identità sostenibile dell’organizzazione può apparire definita non tanto da specifiche dimensioni operative e strategiche, quanto dall’insieme delle percezioni, delle richieste, dei moduli da compilare e delle evidenze da fornire.
Il Parlamento Europeo, con il provvedimento “Stop the Clock” del 3 aprile 2025, ha deliberato il rinvio di due anni per l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione della CSRD per le imprese di media dimensione, e di un anno per quelli relativi alla due diligence CSDDD.
Questo rinvio non deve essere interpretato come un passo indietro: al contrario, rappresenta un’importante occasione per ridurre le duplicazioni, armonizzare gli standard, semplificare senza svuotare, con l’auspicio che le istituzioni europee sviluppino un sistema chiaro, unitario e proporzionale di disclosure ESG.
Una molteplicità di sguardi: “osservatori” e “osservati” nella catena del valore
Ogni impresa si muove all’interno di un complesso reticolo di relazioni in cui non è più sufficiente essere inclusivi ed etici, e avere un ridotto impatto ambientale: è necessario dimostrarlo, renderlo credibile, verificabile e confrontabile.
Molte società private offrono rating ESG, come EcoVadis o Sustainalytics, proliferano le piattaforme come Open-es, CDP, TCFD, le certificazioni (ISO 14001, ISO 45001, EMAS, B Corp, Fair Trade, FSC, Get It Fair-GIF, etc.).
Da una prospettiva “interna” all’impresa, ci si ritrova a ricevere più questionari, più audit e più richieste di dimostrare, documentare, tracciare ogni aspetto gestionale e organizzativo.
Tale abbondanza, pur essendo testimonianza di un interesse crescente verso la sostenibilità, rischia di generare confusione e costi superflui. L’impresa, specialmente se di dimensioni contenute, fatica a dedicare personale qualificato a un “bestiario documentale” che richiede aggiornamenti costanti, pena l’esclusione da appalti e contratti. Da qui la domanda cruciale: come far sì che la necessità di dati e trasparenza non degeneri in un’impasse burocratica, capace di soffocare l’autentico slancio verso modelli di business più sostenibili?
La sostenibilità “percepita”: identità ESG e paradosso della molteplicità
Proprio come il Vitangelo Moscarda pirandelliano, l’impresa oggi rischia di essere vista in mille modi diversi da stakeholder differenti: cliente, banca, autorità, ente certificatore, società di rating.
Il problema non è tanto nella varietà dei punti di vista – che potrebbe anche essere considerato un arricchimento – quanto nella loro incoerenza strutturale. Gli stessi dati vengono chiesti più volte, con formule diverse, da soggetti diversi. I criteri ESG variano da una piattaforma all’altra. La stessa impresa può ricevere valutazioni differenti a seconda del sistema adottato.
In questo labirinto di specchi, l’organizzazione perde coerenza narrativa. Non sa più come raccontarsi e potrebbe perdere di vista cosa significa davvero “essere sostenibile”. Il linguaggio della sostenibilità diventa tecnico, sterile, burocratico.
Eppure, la vera sfida non è certamente rispondere a tutti i questionari, ma costruire un’identità ESG autentica, fondata su strategie, obiettivi e risultati tangibili.
Verso una sostenibilità utile: pragmatismo, proporzionalità, efficienza
Il futuro della sostenibilità passa attraverso una parola chiave spesso trascurata: utilità.
Essere sostenibili deve servire a qualcosa: a migliorare i processi, a ridurre gli sprechi, a valorizzare le persone, a contenere i rischi, a generare vantaggio competitivo. Perché ciò accada, occorre:
razionalizzare le richieste documentali, evitando che ciascun attore (cliente, banca, grande impresa) chieda la propria “versione” dei medesimi dati;
introdurre uno standard unico europeo, adattabile alla realtà concreta, preferibilmente graduale e commisurato al settore di appartenenza, ai potenziali impatti, ai profili di rischio e alle dimensioni dell’impresa;
digitalizzare i flussi informativi, evitando che ogni audit o ogni valutazione ESG riparta da zero;
formare le imprese, anche le più piccole, affinché comprendano che l’ESG non è una tassa da pagare, ma una leva da attivare.
Non sprecare il tempo guadagnato
Il rinvio degli obblighi previsto dal provvedimento “Stop the Clock” è una sospensione responsabile, non un’occasione per disimpegnarsi. Al contrario, impone alle istituzioni europee, agli standard setter, ai principali attori di mercato una chiara responsabilità: quella di costruire un ecosistema ESG più semplice, più coerente, più utile.
Come disse John Maynard Keynes, “la difficoltà non sta nelle idee nuove, ma nel sottrarsi a quelle vecchie”. Occorre superare la logica del moltiplicare richieste, questionari e check list, per tornare a una logica di valore sostanziale, non formale.
La nostra riflessione non vuole sfociare nel pessimismo: è la constatazione della pluralità di sguardi a cui le imprese sono sottoposte e del rischio che tale pressione possa trasformarsi in rigetto. Ma è anche l’occasione per costruire una sola visione strategica e autentica, capace di integrare gli aspetti ESG nel cuore stesso dell’impresa.
Il tempo guadagnato va ora usato per pensare, progettare, semplificare. Non per rinviare, ma per rendere possibile una sostenibilità che funzioni.
Postilla conclusiva. Il nostro Moscarda non deve diventare “nessuno”
Nel romanzo pirandelliano, Vitangelo Moscarda conclude il suo cammino dissolvendo sé stesso: non più uno, né centomila, ma nessuno. La sostenibilità non può permettersi questa stessa fuga. Non possiamo auspicare una sostenibilità evanescente, ineffabile, priva di contorni. Le imprese e le filiere cui appartengono hanno bisogno di una sostenibilità che trovi forma e identità, che si riconosca in una struttura coerente e proporzionata, capace di generare fiducia e orientare le scelte.
Il nostro “ESG-Moscarda” non deve perdersi tra i riflessi, ma ricomporsi in una visione strategica, essenziale e leggibile. Non per compiacere gli sguardi esterni, ma per produrre valore reale, per sé e per gli altri. La sostenibilità, da “centomila percezioni”, può diventare una pratica condivisa, solida e rigenerativa. Non dissolta nel silenzio, ma con lo sguardo fermo, rivolto al futuro.